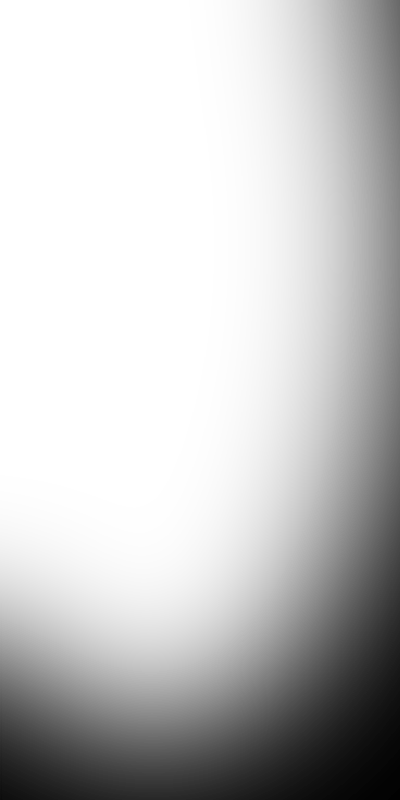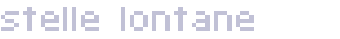
QUALI LE CAUSE?
Intervento di Adriano Gallina sulla lettera aperta di Fabrizio Cassanelli
Caro Eolo,
molto stimolante ed interessante il dibattito tra Cassanelli e Presotto. Ma forse, come immancabilmente accade da qualche anno quando si lamenta il declino motivazionale ed artistico del teatro ragazzi, non viene centrato il problema. Si denunciano gli effetti e - almeno apparentemente - si ignorano del tutto le cause. E le cause sono, a mio modo di vedere, da ricercarsi in ambito politico-organizzativo, non (o non solo) artistico. Il primato dell'organizzazione, teorizzato da Paolo Grassi, si riversa in modo dirompente nell'universo della produzione, determinandone i limiti, i tempi, i temi, gli orientamenti.
Il sistema economico-organizzativo del Teatro Ragazzi - emerge anche in modo evidente dalla ricerca che abbiamo effettuato con Fabio Naggi ed Antonio Massena - è un sistema largamente autopoietico, nel quale produttori e consumatori intermedi (i programmatori) tendono, statisticamente, ad identificarsi. Il Teatro Ragazzi produce Teatro Ragazzi e compra Teatro Ragazzi. E' dunque il Teatro Ragazzi che si produce e riproduce e che - per molti versi - determina ed orienta le regole e gli standard (anche qualitativi) del proprio essere (o non essere) sistema e koiné.
Ora, io ritengo che - con tutto il bene ed il male che si può dire di festival e vetrine - il nodo fondamentale, politico ed organizzativo e dunque artistico si trovi nell'incapacità storica (paradossale, in fondo, in un settore che per molti versi si è venuto autoregolando) di tutelare i repertori nei confronti del consumatore finale (scuole e famiglie), dal quale - incomprensibilmente - abbiamo supinamente accettato (o l'abbiamo imposta noi?) la necessità di una produzione a ritmi serrati, quasi imprescindibilmente annuale, priva dei necessari tempi di maturazione delle urgenze, delle vocazioni, dei momenti di laboratorio e ricerca. Si vengono sempre più avverando le lucidissime profezie già ipotizzate da Morteo nel convegno del 1984 sull'Immaginario Bambino.
I nostri spettacoli migliori campano due-tre stagioni mentre al contrario - per loro natura, dal momento che i bambini se ne vanno dalla scuola (anche se gli insegnanti restano: ma mica produrremo per loro?) - potrebbero sopravvivere economicamente ed artisticamente molto, molto più a lungo. Una sorta di frenesia produttiva che - ovviamente anche e soprattutto nelle vetrine e nelle loro regole - riflette non già o non solo la crisi di vocazioni ma, più probabilmente, l'impossibilità del loro realizzarsi compiutamente. Se devo produrre - perchè questo è il mio mestiere - e devo rendere visibile il mio prodotto (perchè la visibilità coincide con l'esistenza) tenterò il tutto e per tutto in quella vetrina. Ed ecco le crisi di identità, le crisi vocazionali, le compagnie e gli operatori sull'orlo di una crisi di nervi, le cazzate televisive, gli allestimenti d'accatto, gli scimmiottamenti disneyani...
Ma se le vetrine, i festival, il mercato che noi stessi costruiamo iniziassero a difendere i repertori; prendessero in considerazione - come del resto fanno tutti con i propri spettacoli, nelle proprie programmazioni - la possibilità che quello spettacolo, bello, d'eccellenza, di senso e con un senso, venga programmato per una, due, tre stagioni consecutive; iniziassero a negoziare con gli insegnanti e i comuni le proprie prerogative di direzione artistica; ed iniziassero - da produttori - a rifiutare questi ritmi, a rivendicare la necessità artistica delle pause, della ricerca, della riflessione, dell'emergere reale di 'qualcosa da dire'; se tutto questo diventasse - anche e precipuamente - politica di settore, non cambierebbe qualcosa?
In caso contrario le litanie e le lamentazioni non servono a molto: se non all'interrogarsi un po' manierato su una crisi che dura da molto, troppo tempo, ma di cui noi stessi siamo la causa.
Adriano Gallina


Intervento di Adriano Gallina sulla lettera aperta di Fabrizio Cassanelli
Caro Eolo,
molto stimolante ed interessante il dibattito tra Cassanelli e Presotto. Ma forse, come immancabilmente accade da qualche anno quando si lamenta il declino motivazionale ed artistico del teatro ragazzi, non viene centrato il problema. Si denunciano gli effetti e - almeno apparentemente - si ignorano del tutto le cause. E le cause sono, a mio modo di vedere, da ricercarsi in ambito politico-organizzativo, non (o non solo) artistico. Il primato dell'organizzazione, teorizzato da Paolo Grassi, si riversa in modo dirompente nell'universo della produzione, determinandone i limiti, i tempi, i temi, gli orientamenti.
Il sistema economico-organizzativo del Teatro Ragazzi - emerge anche in modo evidente dalla ricerca che abbiamo effettuato con Fabio Naggi ed Antonio Massena - è un sistema largamente autopoietico, nel quale produttori e consumatori intermedi (i programmatori) tendono, statisticamente, ad identificarsi. Il Teatro Ragazzi produce Teatro Ragazzi e compra Teatro Ragazzi. E' dunque il Teatro Ragazzi che si produce e riproduce e che - per molti versi - determina ed orienta le regole e gli standard (anche qualitativi) del proprio essere (o non essere) sistema e koiné.
Ora, io ritengo che - con tutto il bene ed il male che si può dire di festival e vetrine - il nodo fondamentale, politico ed organizzativo e dunque artistico si trovi nell'incapacità storica (paradossale, in fondo, in un settore che per molti versi si è venuto autoregolando) di tutelare i repertori nei confronti del consumatore finale (scuole e famiglie), dal quale - incomprensibilmente - abbiamo supinamente accettato (o l'abbiamo imposta noi?) la necessità di una produzione a ritmi serrati, quasi imprescindibilmente annuale, priva dei necessari tempi di maturazione delle urgenze, delle vocazioni, dei momenti di laboratorio e ricerca. Si vengono sempre più avverando le lucidissime profezie già ipotizzate da Morteo nel convegno del 1984 sull'Immaginario Bambino.
I nostri spettacoli migliori campano due-tre stagioni mentre al contrario - per loro natura, dal momento che i bambini se ne vanno dalla scuola (anche se gli insegnanti restano: ma mica produrremo per loro?) - potrebbero sopravvivere economicamente ed artisticamente molto, molto più a lungo. Una sorta di frenesia produttiva che - ovviamente anche e soprattutto nelle vetrine e nelle loro regole - riflette non già o non solo la crisi di vocazioni ma, più probabilmente, l'impossibilità del loro realizzarsi compiutamente. Se devo produrre - perchè questo è il mio mestiere - e devo rendere visibile il mio prodotto (perchè la visibilità coincide con l'esistenza) tenterò il tutto e per tutto in quella vetrina. Ed ecco le crisi di identità, le crisi vocazionali, le compagnie e gli operatori sull'orlo di una crisi di nervi, le cazzate televisive, gli allestimenti d'accatto, gli scimmiottamenti disneyani...
Ma se le vetrine, i festival, il mercato che noi stessi costruiamo iniziassero a difendere i repertori; prendessero in considerazione - come del resto fanno tutti con i propri spettacoli, nelle proprie programmazioni - la possibilità che quello spettacolo, bello, d'eccellenza, di senso e con un senso, venga programmato per una, due, tre stagioni consecutive; iniziassero a negoziare con gli insegnanti e i comuni le proprie prerogative di direzione artistica; ed iniziassero - da produttori - a rifiutare questi ritmi, a rivendicare la necessità artistica delle pause, della ricerca, della riflessione, dell'emergere reale di 'qualcosa da dire'; se tutto questo diventasse - anche e precipuamente - politica di settore, non cambierebbe qualcosa?
In caso contrario le litanie e le lamentazioni non servono a molto: se non all'interrogarsi un po' manierato su una crisi che dura da molto, troppo tempo, ma di cui noi stessi siamo la causa.
Adriano Gallina